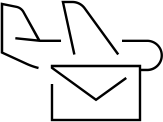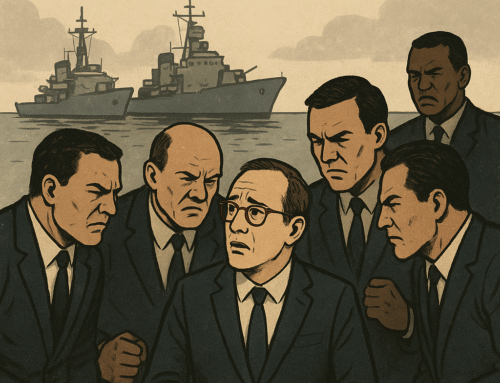India
L’India ha superato il Giappone ed è diventata la quarta economia mondiale. I numeri sono noti: oltre quattromila miliardi di dollari di PIL nominale, una crescita costante, proiezioni che la collocano stabilmente tra i grandi poli dell’economia globale nel prossimo decennio. Ma fermarsi al dato quantitativo significa non capire la portata reale di ciò che sta accadendo. Perché l’ascesa indiana non è solo economica: è demografica, culturale, simbolica. Ed è soprattutto alternativa rispetto al modello occidentale che per due secoli abbiamo considerato universale.
L’India cresce senza assomigliare a noi. E forse è proprio questo il punto.
Nel dibattito europeo l’India viene spesso raccontata come “potenza emergente” che, prima o poi, dovrà convergere verso i nostri standard: Stato sociale, individualismo dei diritti, consumo come misura del benessere, urbanizzazione ordinata secondo criteri funzionali, separazione netta tra sfera religiosa e sfera pubblica. Ma questa narrazione è rassicurante solo per chi la produce. In realtà, l’India sta costruendo una modernità diversa, stratificata, non lineare, in cui il nuovo non cancella il vecchio ma vi si sovrappone.
Qui la crescita economica convive con una vastissima area informale. Il settore tecnologico più avanzato coesiste con villaggi agricoli che funzionano secondo logiche comunitarie antiche. Il PIL cresce, ma il reddito pro capite resta basso se confrontato con l’Occidente. Eppure questo non genera automaticamente disgregazione sociale, perché il sistema non è centrato sull’individuo isolato, ma sulla famiglia allargata, sulla rete, sul gruppo. Dove lo Stato non arriva, arriva la comunità. Non per virtù morale, ma per necessità storica.
Questo modello non è esportabile né idealizzabile. È pieno di contraddizioni, disuguaglianze, tensioni. Ma è coerente con la struttura profonda della società indiana. Ed è proprio questa coerenza a renderlo resiliente.
Un passaggio decisivo riguarda le città. L’urbanizzazione indiana è spesso descritta come caotica, disordinata, ingestibile. In parte è vero, se la si giudica con parametri europei. Ma anche qui l’errore sta nel metro di misura. Le città indiane non sono il risultato di una pianificazione centralizzata novecentesca, ma di una crescita per addizione, per stratificazione. Quartieri informali, mercati spontanei, infrastrutture moderne, templi, spazi sacri e reti di trasporto convivono nello stesso spazio senza cercare una sintesi estetica o funzionale.
L’urbanistica indiana non punta alla separazione delle funzioni, ma alla loro compresenza. Il sacro non viene espulso dalla città moderna; il commercio non viene confinato; l’abitare non è separato dal lavoro. Questo produce congestione, certo, ma anche una densità sociale che l’Occidente ha progressivamente smarrito. Le città europee, sempre più ordinate e regolamentate, sono spesso anche più vuote, più fragili, più sole. L’India accetta il costo del disordine per preservare la continuità della vita sociale.
C’è poi il nodo demografico, che rappresenta forse la vera linea di faglia tra India ed Europa. L’India è un Paese giovane. La sua età mediana è inferiore ai trent’anni. Ogni anno milioni di giovani entrano nel mercato del lavoro, nella città, nella politica. Questo produce pressione, instabilità, conflitto, ma anche energia, aspettativa, futuro. L’Europa è l’opposto: un continente che invecchia, che si restringe, che consuma più di quanto produce demograficamente. Un continente che difende diritti acquisiti, ma fatica a immaginare il domani.
Il problema non è solo numerico. È culturale. Una società giovane accetta il rischio, il cambiamento, l’imperfezione. Una società anziana tende alla conservazione, alla regolazione, alla paura dell’errore. L’Europa continua a pensarsi come misura dello sviluppo umano, ma demograficamente si sta ritirando. L’India, al contrario, non chiede di essere modello universale: procede secondo la propria traiettoria, forte del numero, della continuità culturale, di una visione del tempo non lineare.
Ed è qui che entra in gioco la dimensione culturale profonda. L’India non ragiona secondo l’idea occidentale di progresso come avanzamento irreversibile. Il tempo è ciclico. Le crisi non sono anomalie, ma fasi. Il Kali Yuga – l’età dell’oscurità e della confusione dei valori – non è una superstizione esotica, ma una grammatica simbolica per leggere il disordine del presente. Dove l’Occidente parla di crisi dell’ordine internazionale, qui si parla di offuscamento del dharma. Cambia il linguaggio, non la sostanza.
In questo senso, l’India possiede un vantaggio culturale che l’Occidente ha progressivamente eroso: la capacità di convivere con la contraddizione senza pretendere di risolverla subito. Religione e politica, sacro e quotidiano, tecnologia e mito non vengono separati in compartimenti stagni. Tutto è relazione. Tutto è connessione. Anche il mito non è un residuo infantile, ma una mappa cognitiva che consente di orientarsi dove la razionalità strumentale non basta più.
Come osserva spesso Dario Fabbri, le potenze non si affermano solo per accumulazione economica, ma per coerenza tra struttura demografica, cultura profonda e ambizione politica. L’India non sta cercando di diventare “come l’Occidente”. Sta cercando di diventare pienamente se stessa in un mondo che cambia. E questo la rende imprevedibile, quindi strategicamente rilevante.
La domanda, a questo punto, non riguarda l’India. Riguarda noi. Siamo davvero sicuri che l’individualismo illuministico, che ha prodotto diritti e libertà fondamentali, non sia diventato anche una debolezza strutturale? Siamo certi che la frammentazione dell’individuo, la solitudine sociale, la perdita di reti comunitarie non stiano minando la nostra capacità di reggere urti economici, demografici, geopolitici?
L’Europa continua a proporsi come approdo finale dello sviluppo umano. Ma forse quel modello non è più una meta universale, bensì una specificità storica, figlia di condizioni irripetibili. L’India, con tutte le sue contraddizioni, ci costringe a prendere atto che esistono altre modernità possibili. Non migliori, non peggiori. Diverse.
E forse la vera lezione non è imitare l’India, ma smettere di pensare che il mondo debba necessariamente assomigliarci. In un’epoca di transizione globale, la forza non sta nell’uniformare, ma nel comprendere le differenze strutturali. Chi continua a leggere il mondo con categorie vecchie rischia di non riconoscere il nuovo che avanza.
Come scriveva Kapuściński, non per spiegare ma per avvertire: il problema non è che il mondo cambi, ma che continuiamo a guardarlo con gli stessi occhiali.