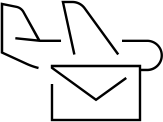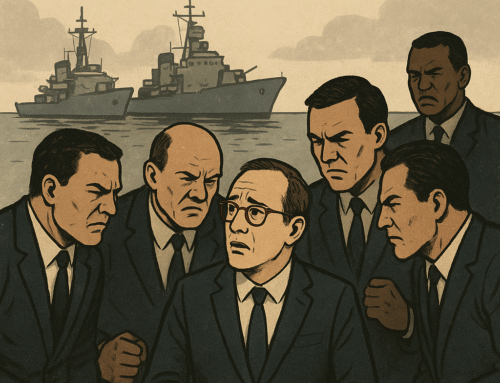Enver Hoxha, leader albanese
Albania, l’avamposto maoista d’Europa
Nel 1973, la Guerra Fredda gelava il pianeta. Blocchi contrapposti di potenze atomiche si fronteggiavano da est a ovest. Ma c’era un piccolo paese, arroccato tra i Balcani e il mare Adriatico, che si era isolato dal mondo. L’Albania, con le sue montagne e le sue ombre, era diventata un enigma. Un avamposto ideologico, un’isola maoista nel cuore d’Europa.
Avevo vent’anni. Ero uno studente universitario con l’animo acceso dalla curiosità. Volevo vedere l’Albania, non da turista, ma da osservatore. Studiavo giurisprudenza, ma la politica internazionale mi affascinava. Scrissi una lettera all’ambasciata albanese. Non fu semplice trovare l’indirizzo, perché l’Albania era un paese senza relazioni ufficiali con quasi nessuno. La lettera era formale, ma piena di passione: volevo un visto per studiare il loro esperimento unico di autonomia. Erano riusciti in quello che sembrava impossibile: spezzare i legami con l’Unione Sovietica, tenere a distanza l’Occidente, e trovare rifugio ideologico nella Cina di Mao.
La risposta arrivò con la stessa durezza del regime che volevo osservare: un rifiuto. Nessuna spiegazione, solo una lettera fredda e impersonale. L’Albania restava chiusa, un paese di bunker e segreti.
Un paese chiuso al mondo
L’Albania di Enver Hoxha era una nazione sospesa nel tempo. Dopo aver rotto con Tito nel 1948, con Stalin nel 1961 e, più tardi, con Mao stesso, Hoxha aveva trasformato il paese in una fortezza. Letteralmente: ovunque si trovavano bunker di cemento, come cicatrici sulla terra. Ne furono costruiti centinaia di migliaia, una difesa paranoica contro invasori che non arrivarono mai.
La politica di Hoxha era guidata da un’ideologia intransigente e da una diffidenza estrema verso qualsiasi alleato. Dopo la rottura con l’Unione Sovietica, accusata di tradire il marxismo-leninismo con le politiche di destalinizzazione di Nikita Khrushchev, Hoxha trovò nella Cina maoista un nuovo alleato. Per un decennio, l’Albania fu il bastione del maoismo in Europa, beneficiando di aiuti economici e militari cinesi. Ma quando Mao Zedong iniziò a riavvicinarsi agli Stati Uniti, Hoxha denunciò anche la Cina come traditrice del comunismo.
Con la fine del sostegno cinese nel 1978, l’Albania si isolò completamente. Hoxha non accettava compromessi: preferiva l’autoisolamento piuttosto che scendere a patti con ideologie che considerava corrotte. Il suo slogan, “Preferiamo mangiare erba piuttosto che inginocchiarci davanti all’imperialismo o al revisionismo”, riassumeva la sua visione autarchica e la sua paranoia.
Bunker: i silenziosi guardiani di cemento

I bunker albanesi sono il simbolo più tangibile di quell’epoca. Sparsi ovunque – lungo le spiagge, nelle montagne, nei villaggi – incarnano la paranoia di Hoxha e il suo progetto di militarizzazione totale del paese. Ogni cittadino doveva essere un soldato; ogni famiglia, una guarnigione.
Costruiti a partire dagli anni ’60, i bunker erano progettati per resistere a bombardamenti nucleari e invasioni di massa. Furono costruiti oltre 170.000 bunker, secondo alcune stime. Piccoli, circolari, con pareti spesse di cemento armato, molti sono ancora lì, fantasmi grigi di un’epoca passata.
Oggi, molti bunker hanno trovato nuova vita. Alcuni sono stati trasformati in musei, altri in gallerie d’arte. Alcuni servono ancora come rifugi improvvisati, luoghi di incontro o addirittura case. Sono cicatrici nella terra, ma anche finestre su una storia che non vuole essere dimenticata.
Relazioni e isolamento
L’Albania è uno dei pochi esempi di un paese che riuscì a distaccarsi sia dall’Unione Sovietica che dalla Cina, rimanendo fedele a una versione estremista del comunismo. Hoxha vedeva nella rottura con le due superpotenze comuniste non una debolezza, ma una vittoria ideologica. Tuttavia, questo isolamento impose al paese un costo altissimo: privato di sostegni economici e di alleati, l’Albania sprofondò in una povertà sempre più profonda.
La politica estera di Hoxha era guidata da un senso di purezza ideologica. L’alleanza con la Cina rappresentò per un breve periodo una boccata d’ossigeno, ma la sua fine lasciò l’Albania più sola che mai. L’autarchia divenne l’unico credo, e con essa, la costruzione di bunker e la mobilitazione forzata della popolazione furono le risposte del regime alla crescente paura di invasione.
Una lezione di confini
Quella lettera di rifiuto mi insegnò qualcosa che non dimenticai mai. L’Albania non era solo un paese chiuso agli stranieri. Era un’idea, un esperimento, e forse una tragedia. Chiusa al mondo, aveva scelto di vivere da sola, e così fece per decenni. Ma quel silenzio l’aveva lasciata indietro, intrappolata nei suoi bunker e nelle sue paure.
Oggi, mentre l’Albania si apre al turismo e alla modernità, resta il ricordo di quel passato. I bunker sono ancora lì, monumenti di un’ideologia che sfidava il mondo. E io, con quella lettera mai accolta, sento di aver toccato almeno un frammento di quella storia.