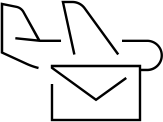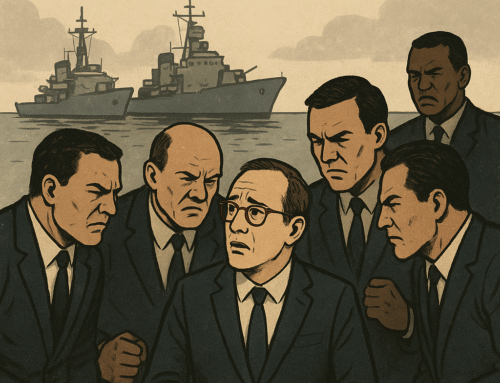effetto serpente
In una recente e approfondita intervista, l’eminente economista Francesco Manfredi, prorettore della prestigiosa Libera Università Mediterranea (LUM), ha affrontato una questione di rilevanza nazionale sollevata da Giorgia Meloni. La discussione verteva sul cosiddetto “super bonus 110%”, un argomento di grande interesse e dibattito nella sfera politica ed economica italiana.
La domanda posta a Manfredi dalla giornalista di Italia Oggi Alessandra Ricciardi riguardava le implicazioni del super bonus 110%, indicato dalla Meloni come un ostacolo al decollo della legge di bilancio, argomentando che le casse pubbliche erano state prosciugate. Manfredi ha risposto con precisione e chiarezza, sottolineando che il costo del super bonus era stato notevole, citando le parole del ministro dell’economia Giorgetti: più di 100 miliardi di euro, di cui ben 80 miliardi ancora da saldare. Questa cifra impressionante richiede seriamente l’attenzione e la considerazione di tutti gli attori coinvolti nel panorama economico e politico del paese.
Tuttavia, Manfredi non si è limitato a presentare i dati finanziari; ha identificato con sagacia tre aspetti critici connessi all’implementazione del super bonus. In primo luogo, ha evidenziato la mancanza di una strategia o direzione chiara nella distribuzione dei fondi, sottolineando la necessità di una gestione oculata delle risorse. In secondo luogo, ha sollevato il problema della percezione pubblica, rilevando come la strategia potesse essere stata interpretata come un tentativo disperato dello Stato di guadagnare il favore popolare, minando la credibilità e l’efficacia dell’intervento. Infine, ha sollevato la questione dell’interpretazione distorta delle parole “remunerazione da lavoro”, dimostrando come alcuni potessero approfittare delle sfumature del linguaggio per ottenere vantaggi impropri.
Le riflessioni di Manfredi mi hanno immediatamente ricondotto a un concetto economico affascinante illustrato dall’economista Horst Siebert nel suo libro “Der Kobra-Effect”. Questo concetto, noto come “Effetto Cobra” o “Effetto Serpente”, prende spunto da un episodio storico dell’India sotto il dominio britannico, in cui la presenza eccessiva di serpenti rappresentava una minaccia reale per la popolazione locale. Nel tentativo di risolvere questo problema, il governo britannico offrì incentivi finanziari ai cittadini per ogni serpente morto consegnato alle autorità. Inizialmente, sembrava un piano brillante: gli incentivi finanziari avrebbero spinto la popolazione a cacciare i serpenti, riducendo così la loro presenza.
Tuttavia, la situazione prese una piega inaspettata. Alcune menti astute decisero di sfruttare il sistema, iniziando ad allevare serpenti per poi ucciderli e richiedere le ricompense. Questo comportamento, indotto dalle distorsioni degli incentivi, ebbe un impatto deleterio, portando a un aumento esponenziale della popolazione di serpenti quando il programma di incentivi fu revocato. Questo episodio storico offre una lezione preziosa su come gli interventi governativi, se non ben ponderati e se non considerano attentamente gli incentivi, possano produrre risultati opposti a quelli desiderati, generando conseguenze impreviste e spesso indesiderate.
In sintesi, l’analisi di Manfredi e l’aneddoto storico illustrato da Siebert sollevano importanti riflessioni sulle politiche economiche e sull’importanza di comprendere appieno gli incentivi e le dinamiche comportamentali prima di attuare interventi che possano avere impatti duraturi e profondi sulla società e sull’economia. Un approccio oculato e attento è fondamentale per evitare gli “effetti serpente” e per conseguire risultati positivi e duraturi per il bene comune.