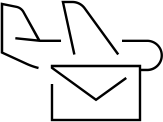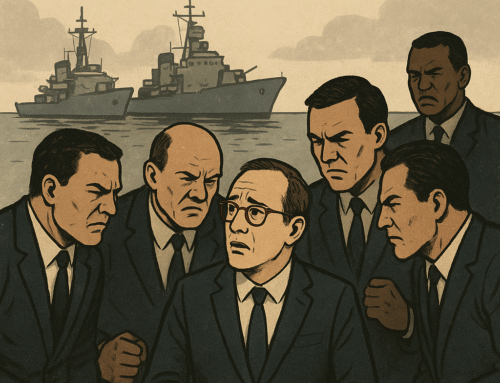Rinascimento e Francesco
In un tempo di fratture e di ritorni, il nome Francesco torna a risuonare con forza. È un nome che ha segnato due momenti critici della nostra civiltà. Il primo fu quello del santo di Assisi, vissuto in un’Europa lacerata dalla guerra, dalla miseria e da una Chiesa avvolta nel potere temporale. Il secondo è quello di Papa Francesco, che si muove oggi nel cuore di un mondo globalizzato in crisi, attraversato da nuove disuguaglianze, da nuove guerre e da una profonda incertezza culturale.
C’è una continuità profonda tra questi due Francesco. Entrambi parlano di fraternità, di povertà come scelta e non come condanna, di rispetto per il creato e per la dignità dell’uomo. Entrambi sono figure di rottura, profetiche e contestate. Entrambi indicano una strada spirituale come condizione per una rinascita civile. È per questo che la loro figura può essere letta come segno di un possibile “nuovo rinascimento”.
Un concetto che oggi torna a farsi largo anche nel dibattito intellettuale, come reazione alla crisi dell’utopia globale. Il filosofo e politico Giulio Tremonti, nel suo ultimo saggio Guerra o pace, lo dice chiaramente: viviamo un tempo non troppo diverso da quello del Cinquecento. Un tempo che appare “scardinato”, per usare le parole di Amleto: The time is out of joint. Allora, nel cuore del vecchio mondo medievale, irruppero una serie di eventi dirompenti — la scoperta dell’America, la rivoluzione copernicana, le guerre di religione — che riplasmarono l’Europa e diedero origine all’Occidente moderno.
E soprattutto, vi fu una rivoluzione tecnologica silenziosa ma radicale: l’invenzione della stampa. La stampa liberò il sapere dalle mura dei monasteri e lo rese diffuso, replicabile, accessibile. Oggi, in un parallelo altrettanto dirompente, viviamo l’avvento dell’intelligenza artificiale. Una nuova “macchina” che promette di trasformare la produzione e la trasmissione della conoscenza, ma che pone anche interrogativi profondi su verità, coscienza e responsabilità. Come allora, anche oggi la tecnica precede spesso l’etica, e il rischio è quello di smarrire l’umano proprio mentre si moltiplicano le possibilità.
Allo stesso modo, come nel Rinascimento si inseguiva il sogno di nuove rotte verso le Indie, oggi guardiamo a Marte come nuova frontiera. Allora le caravelle, oggi i razzi di SpaceX. Allora Colombo e Magellano, oggi Elon Musk e le agenzie spaziali nazionali. In entrambi i casi, un impulso alla scoperta che va oltre il calcolo economico: una spinta quasi spirituale a superare i confini del noto, nel bene e nel male. Il senso del viaggio — fisico, mentale, culturale — resta il segno distintivo di ogni grande passaggio d’epoca.
Ma il parallelo tra le due epoche non si esaurisce nel campo della scienza o delle esplorazioni. Anche sul piano geopolitico ci sono echi impressionanti. Se nel Quattrocento l’evento traumatico che scosse l’Europa fu la caduta di Costantinopoli, che nel 1453 segnò la fine definitiva dell’Impero Romano d’Oriente e la conquista ottomana della cristianità orientale, oggi assistiamo — in forme meno eclatanti ma non meno radicali — alla crisi del primato americano.
Allora, la perdita di Costantinopoli fu vissuta come un’apocalisse: non solo la scomparsa di una capitale millenaria, ma la fine di un ordine simbolico, culturale, religioso. Oggi, la crisi del cosiddetto “impero americano” — tra ritirate strategiche, polarizzazione interna, contestazione globale del suo modello — rappresenta una simile fine di egemonia: meno visibile, ma profonda.
Il centro del mondo si sta spostando, come accadde nel passaggio tra Medioevo e Modernità. Ma quel trauma, nel XV secolo, innescò anche una reazione: fu dopo Costantinopoli che i dotti greci migrarono in Occidente, portando con sé i classici perduti, rinfocolando il sapere, accendendo le torce dell’Umanesimo. Allo stesso modo, oggi, dalla crisi di un modello dominante potrebbe nascere un rinnovato pluralismo, ma solo se l’Occidente saprà riscoprire se stesso non come potenza, ma come coscienza.
Anche Tremonti lo sottolinea: quattro forze hanno scosso le fondamenta della globalizzazione. La “scoperta” dell’Asia, e della Cina in particolare, che ha spezzato l’illusione che la globalizzazione economica coincidesse con una marcia inevitabile verso la democrazia; l’avvento della rete e del nuovo paradigma digito ergo sum; la trasformazione della moneta in puro segno digitale, con un sistema finanziario disincarnato dalla realtà; infine, il ritorno della guerra, simultanea e diffusa, che coinvolge l’Europa e il Mediterraneo, il Baltico e il Mar Rosso.
Tutto questo ha riportato in primo piano una parola che per anni era stata rimossa o considerata sospetta: Occidente. La crisi della globalizzazione ci ha restituito, in modo brutale, la consapevolezza delle differenze tra i popoli, delle fratture storiche e culturali, e del fatto che esiste, nel mondo, un insieme di valori e istituzioni che ci unisce a coloro che ci somigliano. Ma non tutti accettano questa consapevolezza.
Come ha scritto Ernesto Galli della Loggia in un recente articolo sul Corriere della Sera, l’idea di Occidente è mal sopportata da una parte del pensiero progressista e da un certo cattolicesimo contemporaneo. Se ne parla poco a scuola, perché si teme che riconoscere una specificità occidentale possa portare con sé sensi di superiorità o pericolose derive identitarie. Eppure è proprio il rifiuto di riconoscere la nostra storia che rischia di spezzare il vincolo sociale su cui si fonda la democrazia.
La rimozione del patriottismo nazionale è già avvenuta. Ora si mira a rimuovere anche il patriottismo culturale, sostituendolo con un patriottismo costituzionale — astratto, legale, formale. Ma la legge senza una memoria condivisa diventa fragile. Senza una narrazione storica in cui riconoscersi, il cittadino si trasforma in consumatore di regole, non in partecipe di un destino comune.
Riconoscere la propria identità non significa disprezzare quella altrui. Al contrario, è il primo passo per un dialogo vero. E questa è la lezione che ci viene da Erodoto, che Steiner rilancia: “Noi mandavamo navi verso l’Africa per domandare: chi siete, quali sono le vostre leggi? Loro non l’hanno mai fatto con noi”. È una domanda che può apparire ingenua, ma che resta essenziale. E che oggi, forse, è il vero punto di ripartenza.
Il nuovo rinascimento, se ci sarà, non sarà fatto di tecnologie o di riforme. Sarà fatto di ritorni: alla memoria, alla bellezza, alla misura dell’umano. Sarà un’epoca in cui torneremo a chiederci chi siamo, non per chiuderci, ma per aprirci davvero. Come fece Francesco, quello d’Assisi. E come, a suo modo, continua a fare Francesco, quello venuto dalla fine
Fonti:
Tremonti, G. (2023). Guerra o pace: L’Europa tra disordine globale e rinascita della civiltà. Milano: Solferino.
Galli della Loggia, E. (2025, 9 maggio). La rinascita (contestata) dell’idea di Occidente. Corriere della Sera. https://www.corriere.it (link ipotetico se necessario)
Erodoto. (1995). Le storie (M. Giangiulio, Ed.). Milano: Mondadori. (Edizione originale ca. 430 a.C.)
Steiner, G. (1998). Errata: Una vita sotto esame. Milano: Garzanti.