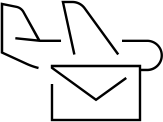OCSE
Gli Stati Uniti, grazie alla presidenza italiana di turno, con una abile mossa diplomatica, hanno ottenuto il sostegno internazionale per l’aliquota globale di imposta, primo passaggio per la revisione delle regole per la tassazione delle società multinazionali.
La prima proposta in tal senso è stata avanzata nell’ambito del G7 dal presidente Biden, aderendo, dopo l’era trumpiana, ad una richiesta dell’Unione Europea.
Il Gruppo dei Sette, di solito abbreviato in G7, è un’organizzazione intergovernativa ed internazionale composta dai sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta, ossia: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, nazioni sviluppate il cui peso politico, economico, industriale e militare è ritenuto di centrale importanza su scala globale.
Esso è nato nel 1975 (ma formalizzato nel 1986), quando il Canada aderì al Gruppo dei Sei: Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America.
L’UE conta con la presenza di una propria rappresentanza, in qualità di invitato permanente, alle riunioni del G7.
L’organizzazione è stata fondata per facilitare le iniziative macroeconomiche condivise dai suoi membri in risposta al crollo del regime di tasso di cambio fisso del 1971, durante il tempo del Nixon Shock, crisi energetica e la conseguente recessione.
Il suo obiettivo era la messa a punto delle politiche economiche a breve termine tra i paesi partecipanti a monitorare gli sviluppi nell’economia mondiale.
I governi dei paesi G7 hanno raggiunto un accordo per una “tassa minima globale”. Dopo quasi un decennio di negoziati che avevano sempre incontrato l’opposizione di Washington, Biden ha accolto le richieste dei governi europei (Francia in testa, Italia e Germania al seguito) che minacciavano di fare da soli.
La rapidità con cui si è giunti a un accordo tra i paesi G7 è stata salutata come un segnale: con Trump uscito di scena il multilateralismo è tornato, e la Casa Bianca è ben contenta di riprendere in mano il ruolo di guida delle “democrazie ricche”.
Ma dietro agli annunci rimane l’opportunismo: Washington aveva bisogno dell’accordo per rendere più attuabile l’aumento di tasse alle proprie imprese senza che queste ultime vadano altrove. Quelle entrate servono a Biden per finanziare il suo piano di investimenti da 4.200 miliardi di dollari.
Ed è proprio negli Usa che si giocherà gran parte della partita: il 72% dei profitti delle 100 multinazionali più grandi è in America. Biden o no, il Congresso americano è già sul piede di guerra.
E il percorso per giungere ad una reale attuazione della norma dovrà prevedere la più ampia partecipazione degli stati. Quindi è stato preannunciato che dopo la definizione del G7 si dovrà procedere ad una approvazione da parte del G20. Dopo il G20 é prevedibile la stesura di un trattato in ambito OCSE e dopo di questo è immaginabile anche una risoluzione del Consiglio Generale delle Nazioni Unite.
Ma il colpo di scena è stata l’accelerazione nell’ambito dell’OCSE.
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – in inglese Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), e in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – è un’organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un’economia di mercato.
L’organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che consente un’occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei paesi membri. Ha sede a Parigi nello Château de la Muette.
Gli ultimi paesi ad aver aderito all’OCSE sono la Colombia (28 aprile 2020) e la Lituania (5 luglio 2018), per un totale di 37 paesi membri.
La partecipazione qualificata e l’importanza della sfida ha permesso la creazione di un “Inclusive Network” con la partecipazione di 136 paesi.
E’ stata una negoziazione iniziata nell’ottobre 2015 che ha condotto alla approvazione di 131 paesi di un piano per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa delle tasse ovunque operino.
La decisione si basa su due “pilastri”.
Primo pilastro – Riallocazione dei diritti di imposizione
Il primo pilastro garantirà una distribuzione più equa dei profitti e dei diritti di tassazione tra i paesi rispetto alle più grandi multinazionali, comprese le società digitali. Ridistribuirebbe alcuni diritti di imposizione sulle multinazionali dai loro paesi d’origine ai mercati in cui svolgono attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che le imprese vi abbiano una presenza fisica. Nell’ambito del primo pilastro, i diritti di tassazione su oltre 100 miliardi di dollari di profitti dovrebbero essere riassegnati alle giurisdizioni di mercato ogni anno.
Secondo pilastro – Meccanismo globale anti-erosione delle basi
Il secondo pilastro cerca di porre fine alla concorrenza sull’imposta sul reddito delle società, attraverso l’introduzione di un’aliquota minima globale dell’imposta sulle società che i paesi possono utilizzare per proteggere le proprie basi imponibili. Si stima che l’imposta globale minima sul reddito delle società nell’ambito del secondo pilastro – con un’aliquota minima di almeno il 15% – generi circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali globali aggiuntive all’anno. Ulteriori benefici deriveranno anche dalla stabilizzazione del sistema fiscale internazionale e dalla maggiore certezza fiscale per i contribuenti e le amministrazioni fiscali.
Alcuni paesi non hanno aderito all’accordo: l’Irlanda, l’Estonia, l’Ungheria, Barbados e St Vincente e Grenadine, Kenia e Nigeria.
L’Irlanda è uno dei otto Paesi che in sede dell’OCSE si è rifiutato di siglare l’accordo sulla tassa minima globale per le multinazionali. Durante il vertice, gli stati hanno concordato di imporre alle multinazionali un’aliquota minima del 15% e hanno stabilito di redistribuire i proventi fiscali tenendo conto di dove i profitti sono stati guadagnati.
Questi termini, però, non sarebbero accettabili per l’Irlanda, che ha convinto alcune delle più grandi multinazionali al mondo a delocalizzare grazie ad un’imposta del 12,5%.
L’Irlanda, però, si è detta aperta alle negoziazioni, che continueranno fino a ottobre, data di scadenza per la definizione degli aspetti tecnici.
Tra gli altri Paesi che non hanno aderito all’intesa ci sono l’Estonia e l’Ungheria, dove le multinazionali sono tassate al 9%, e un gruppo di altri paradisi fiscali, quali Barbados e St Vincent & Grenadine, nonché due Paesi africani, Kenya e Nigeria, che hanno espresso preoccupazione per l’impatto che questi termini potrebbero avere sui Paesi in via di sviluppo.
Al contrario, Paesi come il Lussemburgo e la Polonia, che fanno molto affidamento sulle entrate fiscali delle multinazionali, hanno accettato di cooperare.
Il Wall Street Journal riferisce che le grandi aziende tecnologiche hanno sostenuto la revisione delle norme fiscali anche se ciò significa pagare più tasse, in gran parte perché un accordo aiuterebbe a eliminare la minaccia di un mosaico di tasse nazionali sovrapposte come quelle in Francia e nel Regno Unito “È ormai ampiamente riconosciuto che il le regole fiscali che sono state costruite per un mondo fisico non si adattano davvero a un mondo sempre più online”, ha affermato Nick Clegg, vicepresidente degli affari globali di Facebook Inc., in una conferenza stampa il mese scorso. Ha affermato che Facebook accoglie con favore lo slancio verso nuove regole “per riflettere più pienamente l’economia online nelle entrate e nelle casse fiscali dei governi, e ci aspettiamo che Facebook significhi che molto probabilmente pagheremo più tasse e sicuramente tasse in diversi paesi”.
Ma in più avranno il vantaggio di ottenere un riconoscimento e una disciplina da esso derivate che il diritto internazionale non gli ha mai concesso.