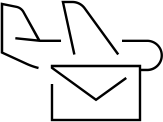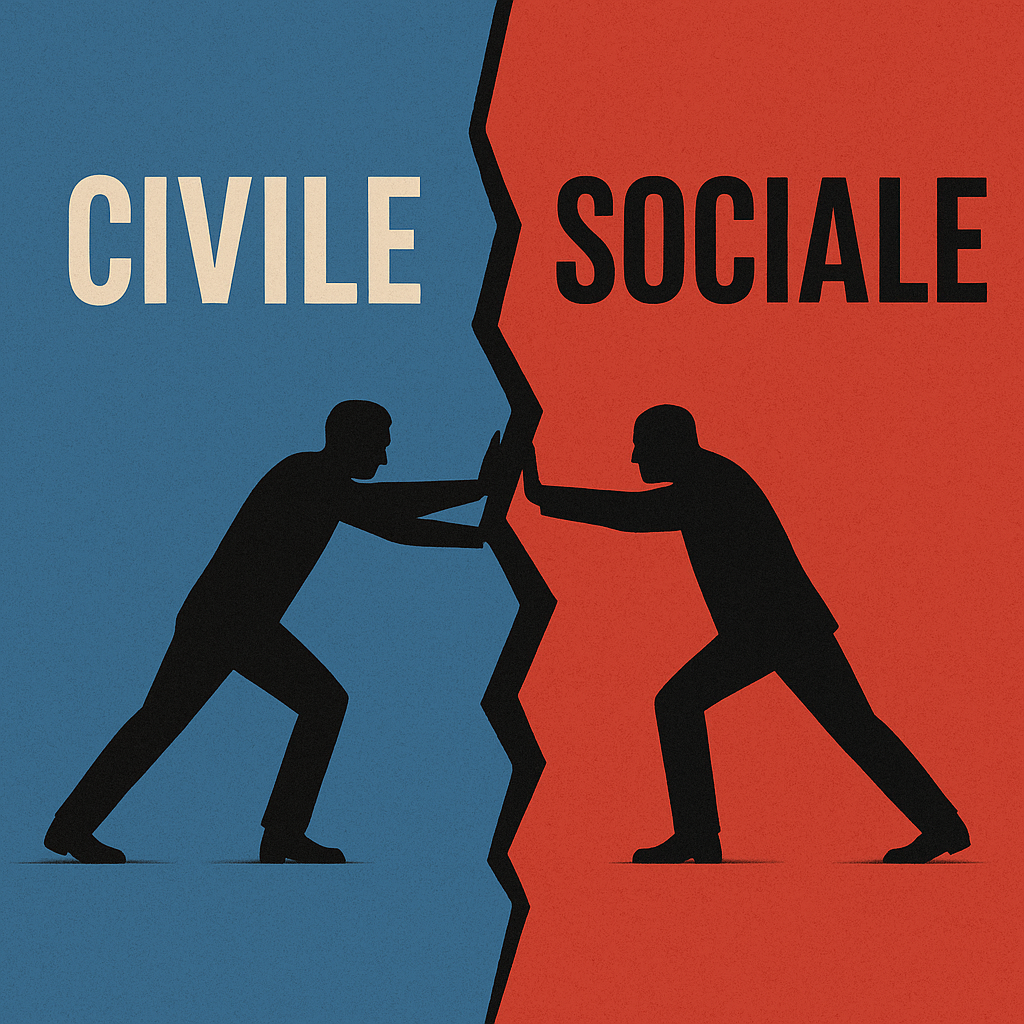
Civile contro il sociale
Civico contro sociale: lo slittamento che indebolisce la politica
Nel suo libro Contromilano, Gianni Barbacetto lancia una provocazione che merita attenzione: la politica – specie quella urbana e locale – sembra sempre più orientata ad affrontare questioni di carattere civico, tralasciando o eludendo i nodi ben più complessi delle politiche sociali. Un cambiamento di paradigma che non è solo semantico, ma profondamente sostanziale. E che rischia, nel medio periodo, di svuotare la funzione stessa dell’amministrazione pubblica.
Diritti civili e politiche civiche: una scorciatoia identitaria
Parlare di diritti civili – dall’identità di genere al linguaggio inclusivo, dalla toponomastica antifascista alle dichiarazioni simboliche su temi globali – è senz’altro importante. La dimensione civica di una comunità ne racconta i valori, la memoria collettiva, l’identità morale. Tuttavia, queste scelte non richiedono grandi investimenti. Spesso si riducono a dichiarazioni d’intenti o provvedimenti simbolici a costo zero. Il loro ritorno è immediato: visibilità, consenso identitario, approvazione nei circuiti mediatici.
Si tratta, in sostanza, di un terreno a bassa intensità gestionale e ad alta intensità comunicativa. Il perfetto equilibrio per chi vuole “fare politica” senza affrontare la fatica della politica sociale.
Politiche sociali: il fronte dimenticato
Le politiche sociali, al contrario, sono lente, complesse, costose. Affrontano problemi concreti: casa, salute, lavoro, povertà educativa, disabilità, invecchiamento della popolazione, nuove marginalità. Richiedono studio, progettazione, risorse, mediazione tra interessi confliggenti, una visione di lungo periodo.
La loro invisibilità è il loro limite nella comunicazione politica contemporanea. Una mensa popolare ben funzionante o un progetto di reinserimento lavorativo non “fanno notizia” come una mozione su un tema di attualità civile. Ma sono ciò che incide davvero sulla vita quotidiana delle persone più fragili.
Milano come caso emblematico
In questo senso, Milano – che Barbacetto osserva con l’occhio del cronista e del cittadino critico – è un laboratorio interessante. La città che si propone come modello di inclusività e modernità spesso trascura le contraddizioni che si annidano nei suoi quartieri popolari, nel disagio abitativo, nella solitudine degli anziani, nella precarietà diffusa tra i giovani.
Il civismo progressista milanese, costruito su un’immagine di efficienza europea e apertura culturale, non sempre si traduce in interventi strutturali sulle disuguaglianze. Si rischia così di costruire una città simbolicamente giusta ma socialmente ingiusta.
Perché questo slittamento piace alla politica
Lo spostamento dal sociale al civico ha un’altra spiegazione: la riduzione della complessità decisionale. Le politiche civiche consentono di schivare il confronto diretto con l’apparato burocratico, con i vincoli di bilancio, con i cittadini organizzati in comitati, sindacati, associazioni di categoria.
In un contesto dove il tempo della politica si è accorciato – scandito dai cicli elettorali e dalla pressione dei social media – la gestione dei problemi sociali appare un investimento a rischio. Troppo lento, troppo poco gratificante, troppo pieno di insidie. Meglio dunque costruire narrazioni. Meglio dichiarare, che fare.
Le conseguenze: sfiducia e disillusione
Ma questo slittamento ha un prezzo: l’aumento della distanza tra istituzioni e cittadini. Il disagio non sparisce perché non se ne parla. I bisogni sociali non si annullano per effetto di delibere valoriali. Al contrario, si radicalizzano, si incancreniscono, si trasformano in rabbia.
Le persone che non trovano casa, lavoro, assistenza o ascolto smettono di credere nella politica. Non vedono differenza tra destra e sinistra, tra progressisti e conservatori. E smettono di votare. O votano in modo rabbioso. Non è un caso che il populismo cresca proprio dove le politiche sociali sono più deboli.
Rimettere al centro il sociale
L’alternativa non è rinunciare ai diritti civili. Ma ricordare che non c’è libertà senza giustizia sociale. Che le città inclusive non sono solo quelle che accolgono le differenze, ma anche quelle che affrontano le diseguaglianze. Che i quartieri periferici meritano lo stesso impegno – e la stessa visibilità – delle grandi piazze dei diritti.
Rimettere al centro il sociale è oggi un gesto radicale. Un ritorno alla sostanza della politica. Un antidoto alla retorica, al marketing, al governo per comunicati stampa. È da lì che bisogna ripartire, se vogliamo una politica che torni a essere credibile. E utile.
Per approfondire
- Gianni Barbacetto, Contromilano. Il modello che non c’è, Laterza, 2024
- Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, Seuil, 2006 – concetto di legittimità per sorveglianza e trasparenza al posto della rappresentanza
- Colin Crouch, Post-democracy, Polity Press, 2004 – sul declino delle politiche redistributive
- Chiara Saraceno, Il welfare: dinamiche e paradossi, Il Mulino, 2020 – sull’invisibilità delle nuove povertà
- Carlo Trigilia, La crisi del welfare urbano, Laterza, 2019 – sullo spostamento dai servizi all’immagine
- Alessandro Coppola, The trajectories of the post-political city, Urban Studies, 2021
- Rapporto ISTAT 2023 sulla povertà assoluta in Italia: istat.it/it/files//poverta2023.pdf
- Codici ricerca e intervento, Fragilità urbane e resilienza, Milano, 2022 – sulle nuove marginalità nelle città italiane
- Fondazione Feltrinelli, Città giusta, 2023 – contributi su città e diseguaglianze
- Dossier Caritas Ambrosiana 2024, Oltre il decoro: le nuove povertà invisibili