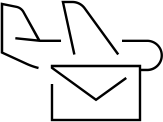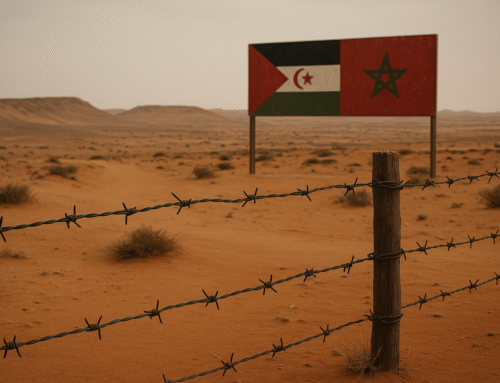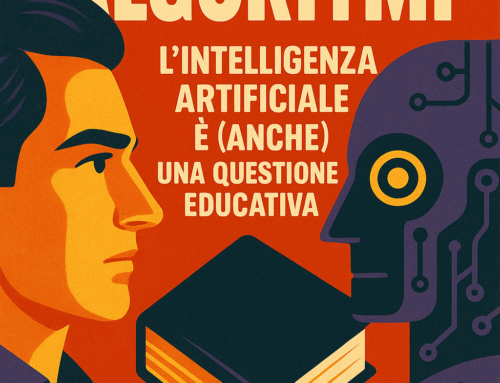Dall’Euratom alla IA
Nel 1957, l’Europa scelse l’energia atomica come il simbolo della propria rinascita tecnologica e politica. La creazione dell’EURATOM con il Trattato di Roma non fu solo un accordo economico, ma un progetto visionario: unire i paesi europei in una missione scientifica e industriale, garantire sicurezza energetica e non restare dipendenti dalle superpotenze.
Oggi, l’Intelligenza Artificiale è la nuova frontiera tecnologica. Stati Uniti e Cina si contendono il primato, investendo miliardi in ricerca e sviluppo. L’Europa, invece, oscilla tra regolamentazioni stringenti e una cronica mancanza di coordinamento. La domanda è se saprà ripetere l’ambizione dell’EURATOM o resterà un’osservatrice.
Alla metà degli anni ’50, il continente era economicamente fragile e politicamente instabile. La Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato l’Europa divisa, mentre Stati Uniti e Unione Sovietica si sfidavano nella corsa agli armamenti nucleari. L’energia atomica era vista come una risorsa strategica: una potenziale fonte inesauribile di energia, ma anche una tecnologia che poteva sfuggire di mano. L’EURATOM nacque per unire gli sforzi europei nella ricerca nucleare e garantire un controllo comune.
Jean Monnet, uno degli architetti dell’integrazione europea, lo spiegò con chiarezza: “L’energia atomica non è solo una risorsa, ma un’opportunità per unire gli europei. Se sapremo condividere questa tecnologia, creeremo una comunità di destino.” Paul-Henri Spaak, uno dei firmatari dei Trattati di Roma, ne ribadì l’urgenza: “Con l’EURATOM, vogliamo evitare che l’atomo diventi uno strumento di morte. L’Europa deve essere un faro di pace, non una polveriera.”
L’entusiasmo si mescolava a una consapevolezza strategica. Alcide De Gasperi vedeva nell’energia nucleare il futuro della sovranità economica: “Il nucleare è la nuova frontiera dell’umanità. Se l’Europa non si unisce, resterà schiava del carbone e del petrolio altrui.” Konrad Adenauer, cancelliere tedesco, fu ancora più netto: “Senza cooperazione nel nucleare, l’Europa non potrà competere con Stati Uniti e Unione Sovietica. È una questione di sopravvivenza.”
Louis Armand, primo presidente dell’EURATOM, sottolineò l’ambivalenza della sfida: “L’atomo è un Prometeo moderno: può donare fuoco agli uomini, ma solo se sapranno controllarlo insieme.”
Il Trattato EURATOM, firmato il 25 marzo 1957, sintetizzò questa ambizione nel suo preambolo: “Gli Stati membri sono determinati a creare le condizioni per lo sviluppo di una potente industria nucleare […] fonte di energia su vasta scala, a vantaggio delle loro economie e a servizio della pace.” L’Europa doveva costruire il proprio futuro tecnologico senza dipendere da Washington o Mosca.
Sessantasette anni dopo, lo scenario è cambiato, ma la sfida è simile. L’Intelligenza Artificiale è la nuova frontiera della competizione globale. Gli Stati Uniti guidano il settore grazie a colossi come OpenAI, Google e Microsoft, mentre la Cina, con il piano AI 2030, ha trasformato l’Intelligenza Artificiale in una priorità nazionale, investendo in modo massiccio e centralizzato.
L’Europa, invece, si trova ancora una volta in ritardo. Il recente AI Act, pur essendo il primo regolamento mondiale sull’Intelligenza Artificiale, rischia di frenare l’innovazione più che incentivarla.
La sfida dell’Intelligenza Artificiale non è solo tecnologica, ma profondamente geopolitica. Stati Uniti, Cina e Russia hanno già riconosciuto il potenziale strategico dell’IA e stanno investendo miliardi per garantirsi un vantaggio competitivo che, nel prossimo decennio, potrebbe ridefinire gli equilibri di potere globali.
Gli Stati Uniti mantengono una leadership consolidata nel settore, grazie alla presenza di colossi tecnologici come Google, Microsoft, OpenAI e Nvidia. La loro strategia si basa su un forte intreccio tra settore privato e pubblico, con investimenti miliardari del Pentagono e dell’amministrazione federale in progetti di IA applicati alla difesa, alla cybersecurity e alla governance dei dati.
La Cina, dal canto suo, sta cercando di colmare rapidamente il divario con Washington. Il governo di Pechino ha dichiarato l’Intelligenza Artificiale una priorità nazionale e ha lanciato il piano AI 2030, con l’obiettivo dichiarato di superare gli Stati Uniti come potenza leader del settore entro la fine del decennio.
La Russia, pur avendo risorse economiche inferiori rispetto a USA e Cina, sta sfruttando l’Intelligenza Artificiale in settori altamente strategici. Mosca ha concentrato i suoi sforzi sulle applicazioni militari e di intelligence, sviluppando algoritmi avanzati per la guerra cibernetica, la disinformazione e le operazioni di guerra elettronica.
L’Europa, invece, appare priva di una strategia chiara. Se l’Europa non vuole diventare un mero consumatore di tecnologie sviluppate altrove, deve cambiare passo.
La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si dice ottimista: “Troppo spesso sento dire che l’Europa è in ritardo nella corsa, mentre gli Stati Uniti o la Cina sono già avanti. Non sono d’accordo, perché la corsa all’IA è ben lungi dall’essere finita. Siamo solo all’inizio. La frontiera è in continuo movimento. La leadership globale è ancora in palio.”
Le parole, però, devono tradursi in azioni. L’EURATOM riuscì perché l’Europa capì che la sfida nucleare non poteva essere vinta da un singolo Stato, ma solo attraverso la cooperazione. Se l’Europa non adotterà un modello simile per l’Intelligenza Artificiale, resterà in una posizione di dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti e dalla Cina.
Mario Draghi, nel suo recente rapporto sulla competitività europea, ha lanciato un monito che sembra valere per ogni stagione: “L’unico modo per diventare più produttivi è che l’Europa cambi radicalmente.”
Nel 1957, i leader europei scelsero l’unità per affrontare la sfida del nucleare. Faranno lo stesso per l’Intelligenza Artificiale?
Negli ultimi decenni, l’Europa ha costruito un sistema economico e normativo pensato per proteggere la propria stabilità. Ma oggi, di fronte alla sfida dell’Intelligenza Artificiale e alle trasformazioni geopolitiche in atto, quella stessa architettura rischia di essere la sua più grande debolezza. Mario Draghi, nel suo recente intervento sul Financial Times, lo ha espresso con grande chiarezza: “Le ultime settimane hanno fornito un duro promemoria sulle vulnerabilità dell’Europa”. La crescita anemica dell’eurozona, la dipendenza strutturale dal commercio internazionale e l’incapacità di sviluppare un’industria tecnologica competitiva sono problemi che l’Unione Europea ha finora evitato di affrontare con decisione.
L’ex premier e presidente della BCE sottolinea come l’Europa si sia sostanzialmente imposta da sola delle barriere che ostacolano il proprio sviluppo. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, le regolamentazioni interne dell’UE equivalgono a una tariffa del 45% per il settore manifatturiero e del 110% per i servizi. L’incapacità di riformare questi vincoli si traduce in una crescita insufficiente e in una dipendenza eccessiva dalla domanda estera. Negli Stati Uniti, il commercio internazionale rappresenta solo il 25% del PIL, in Cina il 37%, mentre nell’eurozona pesa per il 55%. Una fragilità strutturale che espone l’Europa alle tensioni commerciali globali, come dimostrano i recenti dazi americani.
Ma la sfida più grande riguarda l’innovazione tecnologica. Le normative europee, nate per proteggere i cittadini dai rischi delle nuove tecnologie, hanno avuto un effetto collaterale devastante: hanno soffocato la crescita delle aziende tecnologiche europee. Draghi cita il GDPR, il regolamento sulla protezione dei dati, il cui costo di conformità ha ridotto i profitti delle piccole imprese tecnologiche fino al 12%. Un peso che non grava sulle grandi multinazionali americane e cinesi, le quali operano in mercati con meno vincoli e maggiore accesso ai capitali.
Il paradosso è evidente. L’Europa ha creato barriere interne così rigide da limitare la propria capacità di competere nel mondo digitale. Ha costruito un sistema di regole pensato per garantire l’autonomia economica e proteggere i cittadini, ma che in realtà la sta rendendo sempre più dipendente da Stati Uniti e Cina per le tecnologie del futuro. Come ha detto Draghi, “Le barriere interne sono un retaggio di tempi in cui lo Stato nazionale era la cornice naturale per l’azione. Ma agire in questo modo non ha portato né benessere agli europei, né finanze pubbliche sane, né tantomeno un’autonomia nazionale”.
L’Intelligenza Artificiale sarà il prossimo grande banco di prova. Se l’Europa non modificherà il proprio approccio, rischia di trovarsi in una posizione di subalternità permanente. Non basteranno regolamentazioni etiche o dichiarazioni d’intenti per colmare il divario con Stati Uniti e Cina. Servono investimenti strategici, un mercato digitale unico realmente integrato e un coordinamento tra governi e imprese per sviluppare infrastrutture tecnologiche europee.
Nel 1957, i leader europei scelsero di superare le divisioni nazionali e affrontare insieme la sfida nucleare con l’EURATOM. Oggi, la storia si ripete: l’Europa ha due possibilità. Può scegliere di essere una potenza tecnologica indipendente, oppure accettare un ruolo marginale, regolando innovazioni sviluppate altrove. Draghi è stato chiaro: solo un cambiamento radicale può portare l’Europa fuori da questa situazione. La domanda è se ci sarà il coraggio politico per farlo.
Fonti
- Monnet, J. (1976). Mémoires. Fayard.
- Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM). (1957). Archivi storici dell’Unione Europea. Recuperato da https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:11957A
- Spaak, P.-H. (1955). Discorso alla Conferenza di Messina. Archivi storici dell’Unione Europea.
- De Gasperi, A. (1956). Intervista al Corriere della Sera.
- Adenauer, K. (1957). Discorso al Bundestag sulla creazione dell’EURATOM. Recuperato da https://www.bundestag.de/
- Armand, L. (1957). Rapporto EURATOM. Comunità Europea dell’Energia Atomica.
- Joliot-Curie, F. (1958). Critica all’EURATOM.
Fonti sulla geopolitica dell’Intelligenza Artificiale
- Center for Security and Emerging Technology (CSET). (s.d.). Rapporto sulla spesa statunitense in AI. Recuperato da https://cset.georgetown.edu/
- Governo Cinese. (2017). AI 2030 Strategy. Recuperato da https://www.newamerica.org/
- NATO. (2023). Report sulla militarizzazione dell’Intelligenza Artificiale. Recuperato da https://www.nato.int/
- Formiche.net. (2024). Putin e l’Intelligenza Artificiale: il piano della Russia. Recuperato da https://formiche.net/
- Corriere della Sera. (2024). L’Intelligenza Artificiale: la Cina copia gli USA e corre, mentre l’Europa è ferma.
Fonti sulle politiche europee sull’IA
- Unione Europea. (2023). AI Act. Recuperato da https://eur-lex.europa.eu/
- Von der Leyen, U. (2023). Discorso sul futuro dell’IA in Europa. Recuperato da https://ec.europa.eu/
- Draghi, M. (2024). L’Europa ha posto con successo i dazi su se stessa. Financial Times. Recuperato da https://www.ft.com
- Draghi, M. (2024). Report sulla competitività europea. Recuperato da https://commission.europa.eu/
Fonti aggiuntive e approfondimenti
- Krige, J. (2016). The European Atomic Energy Community. Recuperato da https://www.cvce.eu/
- Le Monde. (1957). L’Europa scommette sul nucleare: non più cannoni, ma centrali elettriche.
- Spinelli, A. (s.d.). Discorsi sull’integrazione tecnologica europea. Recuperato da https://www.cvce.eu/
4o